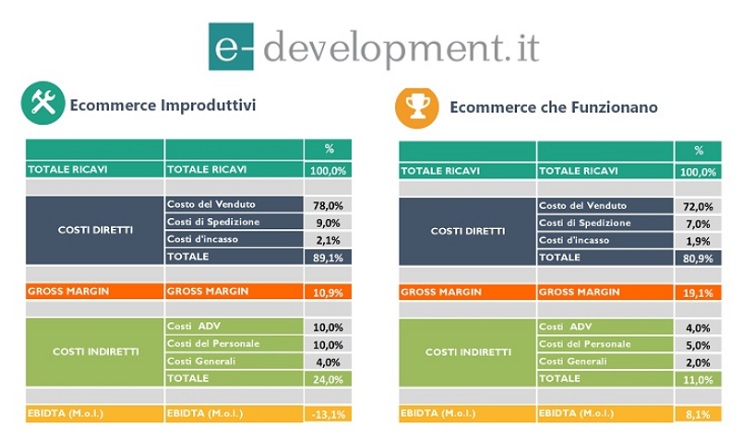Fuga di cervelli in Google
Google è un’azienda relativamente giovane. In meno di 10 anni è riuscita a conquistare la leadership mondiale dei motori di ricerca, una posizione che ha portato l’azienda, secondo la classifica di Fortune, ad essere ritenuta il luogo di lavoro più ambito dagli americani. Ma mentre l’azienda continua la sua corsa solitaria, deve fronteggiare un fenomeno di dimensioni rilevanti, la fuga dei “cervelli”. Oltre un terzo dei primi 300 dipendenti assunti dai fondatori tra il 1998 e il 2002, per lo più ingegneri e matematici, infatti, incassate delle «stock option» milionarie ha lasciato il proprio posto di lavoro in Google.
L’avvicendamento di questi «cervelli» ha comportato l’inserimento di tante nuove risorse, circa 500 al mese, giovani talenti selezionati con metodi di recruiting estremamente originali.
Tecniche che spaziano dai «Google Games», giochi in cui gli studenti di università rivali si sfidano in discipline che vanno dalle costruzioni Lego ai puzzle più complessi, a procedure da «Grande fratello» per uno «screening» di massa dei candidati, realizzato analizzando con un algoritmo matematico i 1300 questionari (ricchi anche di domande su questioni molto personali) compilati ogni giorno da chi vuole entrare nell'azienda di Mountain View. Per i “cervelli infedeli”, una volta fuori dal mondo Google, non c’è che l’imbarazzo della scelta: possono investire in borsa o godersi la fortuna accumulata, o ancora dar vita a nuovi start up (alcuni dei siti sociali di maggior successo sono frutto del lavoro dei fuoriusciti dell'azienda di Mountain View).
I vertici di Google hanno tentato di arginare questo esodo, che provoca ingenti danni all’azienda: rimpiazzare i dimissionari, infatti, significa inserire risorse nuove che necessitano di tempo per entrare in sintonia col team e con il suo modo di lavorare. Ma le strategie adottate non hanno sortito gli esiti sperati: è difficile motivare o trattenere dipendenti ricchi proponendo aumenti di stipendio. Così molti manager sono andati via lamentando che Google sta perdendo la sua anima di «esploratrice della conoscenza» da quando l'attenzione si è concentrata sulla conquista di fette crescente del mercato pubblicitario «on line»; altri, invece, sono rimasti negoziando una rotazione delle mansioni aziendali. Altri ancora hanno giurato la loro fedeltà a Google, come il direttore della ricerca tecnologica, Larry Silverstein, primo dipendente assunto, che ha guadagnato una fortuna in poco tempo e potrebbe incassare altri 100 milioni di dollari dalla vendita delle sue stock option. Abbandonare Google è una scelta forte che non tutti sono pronti a fare, perché al di là dei guadagni, c’è la gratificazione di continuare a lavorare alla soluzioni del problemi matematici posti dallo sviluppo del motore di ricerca, il cuore del «sistema Google».
Oggi Google, che non conosce competitors in grado di minare la sua leadership, ha solo un nemico da cui guardarsi, la sindrome dell'onnipotenza. Non insolita per un'azienda che ha come mission l’analisi e l’organizzazione delle nostre vite con nuovi programmi basati su algoritmi capaci di «ottimizzare» le scelte che facciamo tutti i giorni, che ha polverizzato il concetto di «privacy» analizzando gusti, costumi e abitudini di tutte le persone che dialogano in rete e riproducendo ogni angolo del Pianeta con i suoi satelliti e le migliaia di telecamere sparse in giro per il mondo.
Il fatto che molti lascino quest'azienda è rassicurante. E, in fondo, se ne sono fatti una ragione anche a Mountain View: «Noi — ha dichiarato a Forbes il vicepresidente di Google Laszlo Bock — non vogliamo fare di Google la compagnia più grande del mondo. Se da noi nascono le 200 start up più innovative, non è una cattiva cosa». Anche perché molte di queste aziende, per quanto indipendenti, mantengono un legame tecnologico o operativo con Google.